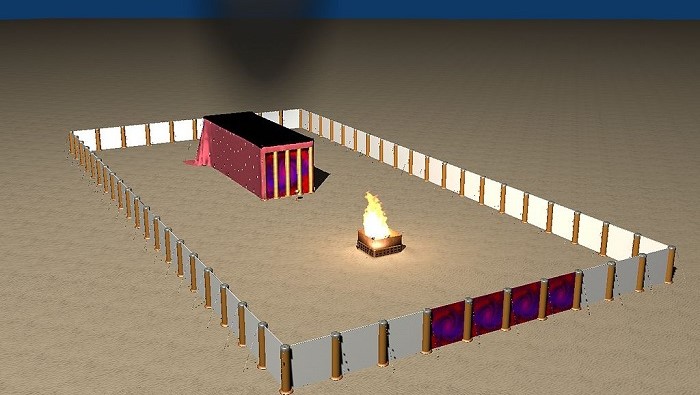Rav Eliahu Birnbaum
Dio allora pronunciò tutte queste parole: “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra…” Esodo 20,2-4.
In questa parashà troviamo per la prima volta i Dieci Comandamenti. I Dieci Comandamenti che furono donati al popolo di Israele come parte dei loro precetti morali e religiosi. Il primo dei Dieci Comandamenti si riferisce alla fede in Dio. Questo primo comandamento afferma che la conoscenza di Dio è allo stesso tempo la negazione degli idoli.
In questo primo comandamento Dio si “presenta” al popolo di Israele insegnando il principio della fede in Dio. La sua presentazione è chiara e concisa: “ Io sono il tuo Dio che ti fece uscire dalla terra di Egitto…” Dio si presenta come il Dio della Storia, un Dio personale che è cosciente di quello che accade al suo popolo e non estraneo rispetto alla sua situazione.
Molte personalità hanno tentato di definire cosa sia la fede. Nonostante si tratti di un concetto antico, ogni generazione prova a definirla per adeguarla alle specifiche necessità del proprio tempo. La fede non è una entità immutabile. Ogni generazione determina le proprie specifiche caratteristiche così come la fede di un individuo non somiglia a quella di nessun altro. La fede è l’apertura dello spirito umano alla presenza di Dio. Ma come percepisce l’uomo la presenza di Dio? Come può testimoniare la sua esistenza? Come è possibile che il Primo Comandamento non dica che l’uomo debba avere fede? La fede si fonda sulla conoscenza del cammino di Dio. Dio si rivela all’uomo attraverso i fenomeni naturali, come colui che determina i successi della vita personale e sociale, come colui che ordina e conduce.
L’Ebraismo non chiede all’uomo di aver fede nei miracoli. Da lui si esige che trovi la forma per giungere alla fede. La fede non è una concessione, né cade dal Cielo. E’ necessario uno sforzo intellettuale, personale, per comprenderla e, in misura ancora maggiore, per sperimentarla. Molte volte le persone sono convinte che la fede sia una questione di fortuna: ci sono persone che nascono con il destino di essere credenti e di avere fede ed altre che nascono non credenti e per questo non hanno alcuna possibilità di giungere ad essa. Non è così la concezione ebraica. Sappiamo dal nostro patriarca Abramo che esistono percorsi per arrivare alla fede e che questi sono alla portata dell’uomo e dei suoi pensieri.
Alcuni dei cammini suggeriti dalla tradizione ebraica per giungere alla fede sono l’osservare la natura e la storia. La natura ci insegna qualcosa circa il Creatore e Colui che guida. Se osserviamo la Creazione, il mondo, l’uomo, possiamo giungere all’innegabile conclusione che sono frutto di una attenta pianificazione. La tecnologia moderna scopre costantemente prove della pianificazione e del “disegno” del mondo nella natura. Ne deduciamo l’esistenza di una forza orientatrice nel principio del processo, ma ciò non basta. La natura continua la sua attività senza sosta. Gli uomini continuano a vivere. Si svegliano al mattino dopo aver dormito. Le piante crescono e gli animali si riproducono. La natura non si ferma. Siamo testimoni di una forza-guida che, oltre ad aver ideato il piano originale, continua ad essere presente per permettere il funzionamento della stessa macchina naturale.
E’ altresì possibile percepire la presenza di una forza che la guida, attraverso l’osservazione dello sviluppo della storia ebraica. L’esistenza del popolo di Israele non è comune né naturale: un popolo che vive migliaia di anni senza un territorio, senza un governo; un popolo i cui nemici e persecutori tentano sempre di distruggerlo e cancellarlo dalla faccia della terra. La spiegazione della sua esistenza fisica e spirituale è l’esistenza di una forza soprannaturale.
Nonostante l’allontanamento dell’uomo moderno dal mondo della fede, il concetto di “fede” si presenta a lui cento, mille volte nel corso della sua vita, fin quando l’uomo si ferma nel suo frettoloso cammino per chiedersi quale sia il suo significato. Qual è l’essenza di questo concetto e qual è la sua importanza all’interno dell’Ebraismo? In realtà non esiste un uomo che viva o possa vivere senza fede. La fede, nel suo senso più ampio, non è legata necessariamente alla fede in Dio. E’ al contrario un sentimento di fiducia in qualcosa d’altro: nei genitori, in un amico, nella società, nei sentimenti e le attività del corpo, nella conoscenza e negli ideali. La fede si rivela in ogni azione dell’uomo.
E’ vero che la fede, nella sua espressione più distinta, vuol dire fede in Dio. La fede è il riconoscimento della Sua esistenza, della Sua supervisione e della Sua relazione con l’uomo ed il mondo. Esistono tipi di fede che si incontrano nell’uomo sin dalla sua fanciullezza ed altri che devono essere acquisiti attraverso lo studio e la comprensione. Il bambino crede in sua madre sin dal momento della sua nascita e lungo tutta la sua vita.
Nella nostra generazione, la generazione della tecnologia e della razionalità, può succedere che l’uomo non arrivi al mondo della fede in Dio tramite la sua mente e il suo cuore. L’individuo deve portare avanti uno sforzo personale ed intellettuale per riflettere sul tema della fede e delle sue implicazioni per l’uomo moderno.
La fede ci accompagna sin dall’inizio della nostra esistenza in quanto popolo, a partire dalla figura di Abramo e attraverso una lunga storia di eventi, di sofferenze e torture, dalla Inquisizione sino alla Shoà. La fede in Dio è stata sempre al centro stesso dell’esistenza ebraica. Generazioni intere sono nate all’interno del mondo della fede. Per varie generazioni gli individui sono stati educati sin dalla nascita ad usi e principi religiosi, in famiglie nelle quali insieme al latte materno, ricevettero i principi della fede nel Dio di Israele.
Non succede lo stesso nella nostra generazione in cui la fede deve essere il risultato di riflessione e di studio. La crisi più significativa nella vita ebraica e religiosa del nostro tempo deriva dalla distanza che esiste tra l’ampiezza delle nostre conoscenze circa la natura e la vita e la ristrettezza del nostro interesse e della nostra conoscenza della vita religiosa e della fede. Mentre avanziamo in tutto quello che concerne la nostra vita pratica e via via perfezioniamo le nostre conoscenze e la nostra tecnologia, nell’ambito della fede e del pensiero restiamo su di un piano retrocesso. La differenza tra la nostra maturità ed il nostro progresso da un lato e quello infantile e primitivo della nostra vita spirituale e della nostra fede dall’altro, sono la fonte della problematica relazione con la fede e la religione.