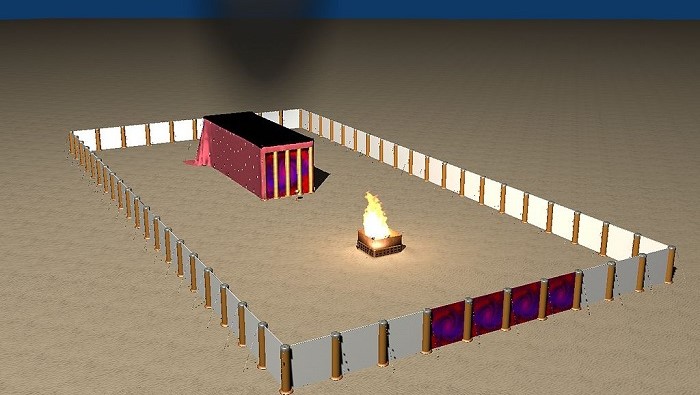Rav Eliahu Birnbaum
Prima di salire sul Monte Sinai, Moshè avverte il popolo di Israele che vi resterà per quaranta giorni e quaranta notti, ovvero per il tempo in cui il Creatore gli donerà la Torà che egli dovrà insegnare al Suo popolo.
“E Moshé tardò…” dice la Torà ed il Talmud interpreta che il ritardo fu di non più di sei ore: secondo il calcolo del popolo Moshè avrebbe dovuto discendere all’alba, invece non apparve fino alla metà del giorno. Furono sufficiente sei ore fugaci per fare in modo che si consumasse una delle più grandi tragedie spirituali della storia del popolo di Israele. Avendo necessità di sicurezza, un popolo che conservava la propria indole di schiavo, dovette crearsi una divinità priva di volontà propria, che agisse su comando di coloro che l’avevano creata, fingendo di governare ed indirizzare.
Di fronte all’assenza di Moshe, di fronte alla lontananza dal suo carisma, l’angoscia non ammette scelte intermedie: il popolo si rivolge ad Aharon e gli chiede la costruzione di un vitello d’oro che diventi una divinità da quel momento in poi. L’ansia può indurre a scelte radicali.
Di fronte ad un ritardo di sei ore, presi dalla disperazione, nessuno fu capace di pensare ad una soluzione transitoria che era invece così vicina: proprio Aharon, fratello di Moshe e sacerdote scelto dal Creatore, che aveva a sua volta un preparazione sufficiente per assumere completamente la guida del popolo fino al ritorno di Moshé. Però nessuno lo sollecitò in tal senso, anzi vollero che egli si assumesse la responsabilità di costruire l’idolo che sostituisse non già Moshé, ma Dio stesso.
Il fatto è che presi dalla disperazione, allora come oggi, tendiamo a non vedere le soluzioni più vicine. L’intero popolo dimentica di guardare al proprio interno e rivolgendosi verso gli orizzonti alieni di altri popoli nemici, prende la decisione di imitarli. D’altronde questi dei alieni, gli dei degli altri, sono sempre a disposizione, non abbandonano, non si muovono, non hanno volontà e quindi sembra che non rappresentino nessun rischio.
Dobbiamo ricavare un insegnamento da questo avvenimento, specialmente ai nostri giorni: nel compiere la propria ricerca spirituale, molti membri del nostro popolo scartano implicitamente la tradizione che hanno ereditato, anche se di fatto non l’hanno mai osservata loro stessi; non le concedono nemmeno il beneficio del dubbio e si lasciano sedurre dalle più diverse dottrine estranee e lontane, le cui caratteristiche più importanti sono l’esotismo, l’estraneità che rappresentano e l’efficacia che magari hanno nel contesto delle loro culture.
Dovremmo invece renderci conto della straordinaria efficacia che ha avuto il corpus normativo della Torà lungo il corso di migliaia di anni e per tutta la nostra tradizione, per mantenere saldo il particolare legame che il popolo di Israele ha con il Creatore. Un corpus normativo che continua a fiorire adattandosi al contesto delle nuove esigenze, proiettando nel futuro quell’eredità che da tempo immemorabile ci identifica.